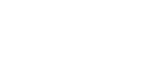Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando torni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Fondazione Palazzo Ducale Genova
Dopo la Storia della Resistenza italiana di Roberto Battaglia, (1953) è stato necessario aspettare quasi quarant’anni prima che uno storico si cimentasse con un’altra storia generale della Resistenza, regalandoci con Claudio Pavone un’opera preziosa come Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della resistenza (1991). Solo con Pavone l’interpretazione storica si affrancò definitivamente dalla monumentalità di quella prima ricostruzione per essere finalmente restituita – attraverso la definizione di guerra civile – all’universo delle tensioni, delle convinzioni, degli atteggiamenti, delle scelte individuali. Per circa quattro decenni, l’unica vera storia della Resistenza è stata quella raccontata dalla letteratura, così che i soli antecedenti dell’universo raccontato da Pavone si trovano non nella saggistica ma in alcuni romanzi, segnatamente in quelli sulla guerra civile dalla parte dei vinti, come Banco di nebbia di Giorgio Soavi o Tiro al piccione di Giose Rimanelli. Il punto più alto di questo filone letterario è quello raggiunto nella trilogia di Beppe Fenoglio (Il partigiano Johnny, Primavera di bellezza, Una questione privata) dove, finalmente, tutta la complessità del reale, ostinatamente negatasi alla conoscenza degli storici, sembra invece offrirsi nella maniera più dispiegata all’indagine letteraria, lasciando affiorare una molteplicità di percorsi esistenziali difficilmente riconducibili ad un’uniformità segnata dalle grandi sintesi politiche e ideologiche. Anche in romanzi come L’Agnese va a morire di Renata Viganò e Il Sentiero dei nidi di ragno ci sono intuizioni straordinarie dal punto vista storiografico: proprio dalla frase del partigiano Kim, uno dei protagonisti del libro di Italo Calvino – «basta un nulla, un passo falso, un impennamento dell’anima, e ci si trova dall’altra parte» – Pavone era partito in uno dei suoi primi tentativi di elaborazione della guerra civile come categoria interpretativa della Resistenza.
Il fatto è che la letteratura sa cogliere e risolvere più intuitivamente quello che altre elaborazioni di pensiero sono più lente a formulare in modo compiuto. È forse da questa constatazione che scaturisce un vecchio complesso di inferiorità degli storici, un sentirsi degli scrittori mancati che, alla creatività di una fantasia capace di nutrire scenari e personaggi, hanno sostituito l’uso dei documenti e delle fonti chiedendo in prestito agli archivi vicende da raccontare e protagonisti da descrivere. Oggi, però, lo storico che ha offerto il suo vissuto autobiografico alla costruzione del proprio progetto scientifico può finalmente liberarsi da queste pastoie psicologiche, nella consapevolezza che, spezzando i compartimenti stagni ereditati dal positivismo, il lavoro sulle fonti non appartiene solo alla fase erudita della sua ricerca ma è parte integrante della narrazione; che il suo racconto finale deve contribuire a far transitare nel senso comune storiografico il sapere storico elaborato secondo i metodi di una disciplina in grado di restituire veramente la realtà dei fatti che si vogliono far conoscere; infine, che questo obiettivo deve essere presente anche nel momento in cui lavora sui documenti, assisterlo nella relazione emotiva che instaura con le fonti (più questa è forte, più è alta l’intensità del suo registro narrativo, la sua capacità di emozionare, coinvolgere il suo lettore).
Ecco, tra le due fasi – quella della ricerca sulle fonti e quella del racconto finale – può esserci al massimo una differenza nella scelta dell’interlocutore ideale, quello che lo storico si raffigura mentre lavora o mentre scrive: nel primo caso, la ricerca delle prove privilegia la comunità scientifica, alla quale deve essere consentito il controllo puntuale di tutti gli elementi che lo storico ha messo in gioco nella ricerca, i suoi documenti, ma anche i suoi principi, la concezione generale del mondo che ne sorregge le argomentazioni, tutti i presupposti dei suoi giudizi di valore; nel secondo caso, quando scrive, lo storico ha presente un lettore con il quale intende comunicare, a cui rivolge un discorso che entra in concorrenza con un’altra pluralità di discorsi (tutti particolari e peculiari forme di storiografia), che affollano la grande arena dell’uso pubblico della storia, uno spazio molto più vasto di quello della comunità scientifica.
Per non soccombere in quell’arena, lo “storico-narratore” deve accettare la sfida del romanzo e della narrativa, cogliendovi molteplici opportunità sia sul piano metodologico (accentuando le distanze dal modello economico deterministico di spiegazione storica), sia su quello dei rapporti tra le varie discipline (sostituendo, per esempio, l’antropologia alla sociologia e all’economia come la più influente delle scienze sociali). Ne deriva uno scossone salutare per gli aspetti più tradizionali dello statuto scientifico della storia, che proprio in anni recenti ha dimostrato di potersi occupare senza remore di sentimenti, emozioni, modelli di comportamento, del desiderio sessuale, dei rapporti familiari, dei vincoli emotivi, sottraendosi all’ossessione di raccontare una storia lineare e assumendo invece esplicitamente come un proprio progetto quello di “vagare nella testa della gente”; si tratta di selezionare i temi e le fonti congrui all’interno di queste coordinate metodologiche e, perché no, in qualche caso, anche abbandonarsi al piacere di raccontare una bella storia.
Giovanni De Luna